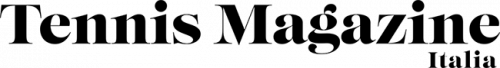100 anni di Centre Court, tra presenti... e assenti
Wimbledon ha celebrato il secolo di vita dell'impianto che nel 1922 prese il posto di quello di Worple Road. Una parata di stelle, sublimata dall'ovazione per Roger Federer. Eppure aleggiava l'ombra di altri campioni che avrebbero avuto il diritto (acquisito o morale) di esserci.
Alessandro Marinaro | 4 luglio 2022 |
Sarebbe superfluo parlare di chi c’era. Mac Supermoccioso, che chiamare John McEnroe per esteso sembra fn troppo serioso, unica e ultima vera rockstar (nel significato più autentico della parola) della racchetta, ormai a suo agio anche come maestro di cerimonie. Lui con il microfono, poi tutti gli altri e le altre con il badge violetto di chi entra nell'All England Croquet and Tennis Club per meriti sul campo. Più che occupare il numero di parole concesse a stilare l’elenco dei presenti, divisi per numero di vittorie in singolare, pare più sensato tentare di far vedere quelli non c’erano, divisi per motivi presunti o accertati. Chi voleva esserci, e non poteva. Chi poteva esserci, e non voleva. Poi la categoria speciale di quelli che avrebbero voluto esserci, o meglio, di quelli che avrebbero dovuto esserci o che avrebbero voluto poterci essere. In questa descrizione per sottrazione, senza la pretesa di rendere giustizia a tutti, si potrebbe partire da Martina (Navratilova, nel caso ci fosse bisogno del cognome) fermata dallo stesso virus che ci ha privato di Berrettini.
Il più grande animale da rete che si sia mai visto in cinquecento anni di tennis, che ha vinto venti volte ai Championships (tra singolo, doppio e doppio misto), la prima nel 1978, l’ultima nel 2003. Gioca ancora adesso, nel doppio delle leggende, con l’augurio di riprendersi e tornare a rete il prima possibile. Soprattutto, con l’augurio di non smettere mai. Finché Martina stringerà ancora il manico di una racchetta, ci sarà ancora speranza a questo mondo. In singolo ha vinto nove volte, e sarebbe stata l’unica che avremmo visto entrare dopo Federer. La ricorda Billie Jean, capelli a spazzola, con gli occhiali tondi sempre abbinati alla giacca, con la vena polemica che non ha ancora perso. Il sottotesto è grossomodo “vedete che è lei, una donna, e pure gay, quella che ha vinto di più qua sopra, quella che entra in campo per ultima, anche se non c’è”. Aggiungiamo: al mondo ci sarà ancora speranza finché Billie Jean avrà ancora voglia di combattere. Forse anche finché il vecchio Rocket si reggerà in piedi. Forse avrebbe voluto esserci Boris Becker, il più giovane ad aver mai vinto, ricordato da nessuno per il suo debito con la giustizia. Jimbo e Serena? Difficile capire in quale categoria inserirli, come i coniugi Agassi-Graf.


La carrellata di campioni nella celebrazione per il secolo di vita del Centre Court
Data la scelta di concentrarsi sui campioni del singolo, mancano gli specialisti del doppio, scegliendo di ignorare anche il fatto che in tanti, tra i presenti, lo sono stati. Forse saranno gli Slam vinti in doppio a valere mezzo Slam, forse il doppio a valere mezzo tennis, o ci sarà stato troppo poco spazio in mezzo al campo per accoglierli tutti? Troppi metri quadri di moquette verde da stendere per non rovinare il prato? Non ci è dato sapere. Avrebbero voluto esserci, e non hanno potuto, tutte le anime dei grandi del passato più lontano, compresi i primi, quelli che hanno vinto quando il tennis era ancora un gioco. Ci rimane l’immaginazione per consolarci, pensando alle ombre degli altri grandi australiani e americani che non ci sono, e poi di Arthur Ashe, della Divina Suzanne Lenglen, dei Moschettieri e di Big Bill Tilden morto in povertà, ignorato dal mondo, con qualche racchetta e un paio di scarpe come eredità. Non gli sarebbe dispiaciuto ricevere un’ultima ovazione sul Centre Court, lui malato di pubblico e di palcoscenico. Nell’indecisione sul chi piazzare nella seconda categoria, degli aventi diritto a un invito che non hanno voluto esserci, c’è un solo nome sicuro. L’orso vero, nel pelo e nei fatti, altro che Borg. A parte l’ombra di Willie Renshaw, sarebbe stato l’unico ad entrare in mezzo a Djokovic e Federer. Il più schivo, silenzioso, il meno celebrato anche perché è quello che ha voluto farsi celebrare di meno. Sampras l’abbiamo visto due, tre, quattro, forse cinque volte dopo gli US Open 2002, nel 2010 ha quasi litigato con Agassi davanti a uno stadio pieno, nell’imbarazzo di Federer e Nadal. Che non gli siano mai piaciute interviste, celebrazioni, premi alla carriera, ospitate e rimpatriate è evidente.
C’è qualcosa di più, come se fosse rimasto troppo doloroso per Pete mettere piede su un campo da tennis senza poterlo fare per poi uscirne vincitore. Il meno volte possibile. Potrebbe averlo giurato a se stesso, non ci sarebbe niente di strano. Da qui anche il ritiro dopo l’ultimo Slam, quello che aveva vinto da dead man walking, nel momento in cui aveva realizzato che forse non ne avrebbe vinti altri. Lo ha ricordato, invece, quello che proprio sul Centre Court è diventato il suo erede. A lui le rimpatriate continuano a piacere parecchio. Rimane l’ultima categoria, la più dolorosa, popolata di personaggi che sembrano usciti più da un romanzo che da un campo da tennis. La categoria di quelli che avrebbero dovuto vincere Wimbledon, per affinità tennistica coi prati e perché i versi di Kipling che presidiano le porte del Centrale parevano scritti per loro, che non hanno potuto per strani scherzi del destino. Ombre o no, avremmo voluto vederli lì con gli altri. Tra loro ci sono gli ultimi attaccanti, Pat Rafter e Tim Henman, quasi troppo educati per vincere di più (Henman c’era lo stesso). Poi Ken Rosewall, disturbando lo Scriba per avergli appiccicato il più bel soprannome nella storia del gioco. Rimane un assurdo logico, un ossimoro, un paradosso o comunque vogliate chiamarlo, che muro di rose non abbia mai trionfato ai Championships. Rientra meno nella descrizione precedente il seppur romanzesco Pietrangeli, ma la semifinale del 1960, persa con Laver, rimane troppo bella e troppo dolorosa per non valergli un posto nell’elenco. Del tutto fuori dalla descrizione iniziale Ivan Lendl, due volte in finale, che però lo aveva voluto più di ogni altra cosa al mondo.


Edberg, Nadal, Kvitova e Murray prima della passerella sull'erba del Centrale
Vincitore di sette edizioni dei Championships, Pete Sampras è stato forse il più celebre assente alla celebrazione pee i cento anni del Centre Court
Ci resta il barone Gottfried von Cramm, altro due volte campione a Parigi, che non ha mai smesso di giocare con i pantaloni lunghi. Alto, biondo, impeccabile, discendente dell’antica nobiltà germanica della Bassa Sassonia. Aristocratico, omosessuale, antinazista. Tra Lutz Long e il Konradin von Hohenfels immaginato da Fred Uhlman nell’Amico ritrovato. Rifiutò un matchpoint nella finale interzone della Davis del ’35 contro gli Stati Uniti per qualcosa che solo lui aveva visto in tutto lo stadio. Clerici avrebbe voluto curarne la biografia, il barone educatamente declinò l’offerta. Il suo match decisivo, perso con Don Budge, in un’altra finale interzone (quella del ’37) giocato sul Centre Court e raccontato da Marshall Jon Fisher in Terribile splendore, è più leggenda che storia. Nel ’39, quando a vincere a Church Road fu Bobby Riggs, che aveva scommesso sulla sua vittoria in singolo, doppio e doppio misto (Billie Jean lo sa, a tennis non si deve mai scommettere contro Bobby Riggs) von Cramm, favorito e tre volte finalista, non poté partecipare perché ritenuto moralmente “unfit” da qualche ominicchio burocrate. Era stato condannato a un anno di carcere per omosessualità, rilasciato dopo sei mesi grazie alle consistenti pressioni internazionali su Hitler, incluse quelle di altri giocatori capeggiati dallo stesso Budge, e quelle del re tennista Gustavo V di Svezia, suo amico.
Tornato a competere nel maggio del ’39, gli fu permesso di giocare al Queen’s, dove vinse lasciando un solo game a Riggs, che forse contro di lui non avrebbe scommesso. Per gli stessi motivi, gli venne negata la partecipazione anche agli US Championships di quell’anno e nel ’40, venne richiamato nella Luftwaffe a combattere sul fronte orientale. Tra i pochi sopravvissuti nella sua compagnia, venne poi congedato nel ’42 con croce di ferro in seguito a un assideramento. Tornò a giocare dopo la guerra, ritirandosi da campione di Germania nel ’49, a quarant’anni. Presidente della federtennis tedesca e imprenditore, morì nel ’76 in un incidente d’auto al Cairo. Ne Il castello dei destini incrociati, Italo Calvino riprendeva Ariosto e diceva: “È in cielo che tu devi salire, Astolfo, su nei campi pallidi della luna, dove uno sterminato deposito conserva dentro ampolle messe in fila, le storie che gli uomini non vivono, i pensieri che bussano una volta alla soglia della coscienza e svaniscono per sempre, le particelle del possibile scartate nel gioco delle combinazioni, le soluzioni a cui si potrebbe arrivare e non si arriva”. Forse, nella dimensione lunare di Ariosto e Calvino, Bobby Riggs ha perso la sua scommessa. Il barone Von Cramm ha vinto Wimbledon, e la sua ombra sorride sul Centre Court, con un paio di pantaloni bianchi perfettamente stirati e una coppa di champagne tra le dita.