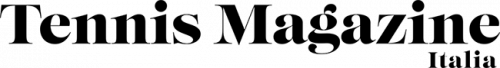«Fui un cretino...»
Per Adriano Panatta è stato «il più grande rimpianto della mia carriera», la sconfitta nei quarti di finale a Wimbledon 1979 contro l'americano Pat Du Pré. Che abbiamo rintracciato, a 40 anni di distanza. E che la pensa in maniera molto diversa...
Federico Ferrero | 9 luglio 2020 |
Se stavi ad ascoltare alcuni, tutti quelli contro cui perdevo facevano i camerieri». Adriano Panatta non è uomo da amarcord, dice di preferire il presente; le rievocazioni le lascia volentieri agli altri, i trofei li perse chissà dove nel mezzo di un trasloco, come i pezzi dell’aspirapolvere vecchio «perché sanno di mausoleo» e tutte le racchette – non una, tutte - le regalò, appena fuori dal Foro Italico, a un ragazzino che gliene aveva chiesta una per ricordo, dopo l’ultima sconfitta al torneo di Roma. La storia del cameriere riguardava Peter Szoke, davisman ungherese che batté il numero uno azzurro nel 1978, dando la stura a un’ondata di bufale ante litteram: qualcuno scoprì che costui figurava come responsabile della ristorazione dell’aeroporto statale di Budapest, circostanza vera e assimilabile ai nostri atleti rappresentanti di qualche forza armata, ma dimenticò di rimarcare che fosse stato uno dei primi 50 del mondo e avesse vinto un torneo del Grand Prix. La notizia suonò perfetta per un titolo da sparare in edicola: scandalo, Panatta umiliato da un cameriere.
«Fui un cretino. Non dico che contro Tanner avrei vinto di sicuro, ma non mi faceva paura. E Borg sapeva che potevo batterlo: l’occasione di poterlo affrontare sull’erba mi piaceva. Un po’ troppo, mi sa» Adriano Panatta
Accanto al titolo di Wimbledon 1979, invece, c’è un rimpianto autentico. «Il più grande della mia vita» dice lui, se ripensa al titolo di una storia che il tempo ha levigato come una pietra sul litorale, lavando via gli spigoli dei particolari e, forse, anche parte della sua sostanza. Però, certe cronache tendenziose e la memoria collettiva, forse per offrire un senso al rimpianto, vogliono che lo sciagurato Panatta fosse stato lo Sciupone per antonomasia, il campione beffato da uno brocco sulla strada di un trionfo già scritto. Circostanza aggravata dal fatto che, quel pomeriggio, Panatta giocò il suo unico quarto di finale di sempre ai Championships: non era abitudinario degli ultimi turni negli Slam, anzi, in dieci Wimbledon giocati si era sempre fermato prima della domenica di mezzo, quella che separa i terzi turni dagli ottavi di finale. Una disgraziatissima partita, da vincere a mani basse contro una mezza calzetta.

A fargli compagnia a bordo campo, e a cena con Vilas e Nastase, si era intrufolato – spacciandosi per il suo coach – Paolo Villaggio, ed è lecito ritenere che quel formidabile compagno di scorribande abbia contribuito a ravvivare il clima competitivo
Sono passati 41 anni da quei Championships, i quarti in fila vinti da Borg, che spezzò in finale Roscoe Tanner, un pitbull mancino di Chattanooga capace di servire a 230 chilometri orari usando racchette che, viste oggi, paiono retini per le farfalle. In semifinale, Borg aveva strizzato per bene Jimmy Connors, mentre Tanner avrebbe dovuto incrociare la racchetta con Adriano Panatta. Invece, sul tabellone, si legge un altro nome, alieno alla leggenda del tennis: Pat Du Pré, Stati Uniti. Che cameriere non era ma scarso sì, secondo la voce del popolo: almeno, come tale venne raccontato colui che aveva ucciso il sogno di vedere un italiano giocarsela per il titolo, perché il miglior azzurro di sempre a Church Road rimane tuttora Nicola Pietrangeli, battuto in semifinale nel 1960 dal grande Rod Laver, 6-4 al quinto set. Sicché Panatta mollò partita e ambizioni di vittoria in un altro Slam, dopo l’epico Parigi ’76, contro questo misterioso tizio dal cognome francofono, E, ancora oggi, non ha dubbi: «Fui un cretino. Perché non dico che contro Tanner avrei vinto di sicuro, ma non mi faceva paura. E Borg sapeva che potevo batterlo: l’occasione di poterlo affrontare sull’erba mi piaceva. Mi piacque un po’ troppo, mi sa».
L’antefatto non è in dubbio: quell’anno, Panatta non era testa di serie. Poteva essere sorteggiato contro chiunque. Fu fortunato: nel suo lato di tabellone il più forte, il fuoriclasse Arthur Ashe, campione nel 1975, era a fine corsa e si era fatto sorprendere da un doppista australiano. Però Adriano aveva appena rimediato una scoppola al primo turno del torneo di Surbiton contro il gigantesco Hank Pfister e, dopo due giorni di mediocri allenamenti a Wimbledon, prese una decisione scapigliata, alla Nick Kyrgios: «Giocavo talmente male che scappai via. Me andai dritto dai campi a Heathrow, senza neanche passare per l’albergo. Presi l’Alitalia Londra-Pisa e raggiunsi mia moglie a Forte dei Marmi, per un weekend di mare». Tornò, svogliato, appena in tempo per disputare il miglior primo turno che si potesse chiedere, contro Ángel Giménez, un pedalatore da terra rossa in atroce difficoltà sui prati. Mal che fosse andata, sarebbe tornato in spiaggia. Fu un ingresso morbido e un po’ naïf nel più abbottonato e prezioso dei tornei, anche perché l’azzurro si trascinava un dolore alla schiena cronico e covava poche aspettative, in un’annata di rare gioie sportive. A fargli compagnia a bordo campo, e a cena con Vilas e Nastase, si era intrufolato – spacciandosi per il suo coach – Paolo Villaggio, ed è lecito ritenere che quel formidabile compagno di scorribande abbia contribuito a ravvivare il clima competitivo. Nell’incontro successivo, affrontò su un campo secondario un ragazzone inglese armato di wild card e gran servizio, Jonathan Smith, e dovette recuperare nel quinto set per spegnere il suo gioco erbivoro. Sconfitti per tre set a zero un invecchiato Ove Bengtson e Sandy Mayer (poi numero 7 ATP ma a lungo infortunato, in quel 1979), ecco spalancarsi i quarti di finale: il 3 luglio 1979 poteva esserci di là dalla rete Gerulaitis, quarto favorito del torneo, e sarebbero stati guai perché il povero Vitas, defunto tragicamente a 40 anni per le esalazioni di monossido di una stufetta, sull’erba valeva più di Panatta. Però il capelluto attaccante di Brooklyn, due volte campione a Roma e animatore di serate indimenticabili al Piper, aveva perso al quinto set contro un tipo dal fisicaccio forzuto e dal curriculum scarno, nato a Liegi ma cresciuto in Alabama. Si chiamava Patrick Du Pré. Con due pennellate su Il Giorno, Gianni Clerici ne diede una descrizione letteraria: «Un bambinone lungo, dal nasetto inesistente, la fronte ridotta a una sottile lista di pelle aggrottata».
Una ricognizione dei dati suggerisce che, quel Du Pré, proprio ignoto non era: semplicemente aveva concluso i corsi universitari, storicamente ostativi della carriera pro (gli studenti Usa non possono prendere soldi per competizioni sportive); dopo la laurea a Stanford, si era fatto largo in classifica molto alla svelta, da 300 a 100 il primo anno di attività, poi 50, poi 40. A Wimbledon del 1979 arrivò come 37esimo giocatore del mondo, con già quattro finali nel Grand Prix in manco 12 mesi, compresa quella del Japan Open (persa, guarda un po’, contro Panatta: ma, ai tempi, là si giocava sul rosso e quello era terreno di Adriano). Superato Gerulaitis 6-3 al quinto set, Du Pré avanzò a spese di Carlos Kirmayr, di un 19enne Yannick Noah, poi passò 8-6 al quinto set su Bob Lutz, un ottimo attaccante con titoli Slam in doppio.
Panatta partì come un rullo: 6-3, 4-0. «Per un set e mezzo non gli feci capire quasi nulla. Lui era un giocatore tosto, precisino, robusto, steady come amano dire loro. Andava tutto liscio, iniziai a pensare alla finale: contro Borg, sull’erba. Un po’ mi sono distratto: non mi era mai successo di sottovalutare un avversario, non ero il tipo, in campo ero sempre serio e concentrato. Ma evidentemente pensai di avercela già fatta, fu un errore terribile. Persi quel set in maniera inspiegabile: lui iniziò a farmi un break, 4-1, 4-2… La partita si impicciò all’improvviso».

A raccontare il lato B della storia è proprio Pat Du Pré, che oggi ha 66 anni e vive felice, «lontano dai riflettori, insegnando tennis a Savannah e godendomi i nipoti». Non fa il coach, non va in televisione, sul web compare solo in qualche serata di carnevale dell’alta società del sudest a sovrastare, col suo metro e novanta, gli amici in festa. In quel luglio aveva 24 anni ed era una belva feroce, un fascio di muscoli con una ottima opinione di sé, utilissima in uno sport mentale non meno che fisico: «Mi spiace ma non mi sono mai sentito l’underdog, lo sfavorito. Avevo paura della partita, molto più che di Panatta. Ero nervoso perché non avevo mai giocato sul campo centrale di Wimbledon ed era un quarto di finale. Solo nel primo game, servii quattro doppi falli».
La cronaca riferisce che Panatta, dal 4-0, perse non sei ma sette giochi di fila, senza neanche ottenere una palla game: più che una pausa, un tracollo. Du Pré la ricorda così: «Non mi suggestionai, non mi sentii mai fuori dalla partita. Ero abituato a resistere. Sull’erba, coi rimbalzi bassi, il mio tennis funzionava, avevo un buon timing: contro gli attaccanti come Panatta, o Noah, o lo stesso McEnroe, gente che amava controllare il punto, cercavo di attaccare per primo e toglievo loro l’iniziativa. Facevo serve&volley. Diciamo che non ero uno che aveva colpi vistosi ma ero solido e lottavo fino all’ultima palla». Soprattutto, non conosceva il concetto di panico o intimidazione: «Ricordo che in un torneo nazionale, qualche anno prima del ’79, stavo vincendo facilmente contro John McEnroe e lui, ovviamente, si lamentava di tutto. Al cambio campo gli dissi: 'Ehi, Mac, siediti, datti una calmata, prenditi le tue legnate e vattene a casa'. Ero fatto così. Non mi facevo impressionare dai nomi altisonanti. Contro Panatta avevo perso in finale a Tokyo, non era stato un match molto… amichevole. A Wimbledon potevo rifarmi. Anzi: quando seppi che Adriano aveva battuto Mayer fui sollevato perché, contro Sandy, avevo sempre avuto problemi». Ripresosi dalla batosta, Panatta vinse il terzo set, al tie-break. Ma, ormai, era diventata una lotta e il vantaggio tecnico sparì, posto che quello psicologico non diede mai notizie di sé e, contro Adriano, non c’era il somaro che qualcuno provò a inventarsi, aiutato dalla sottocultura per cui tutti quelli che non vincono Slam sono dei falliti.

Tra il pubblico, con i biglietti meno esosi, c’erano parecchi giovani italiani che intonavano cori estranei al codice di Wimbledon e mal digeriti dai locali (a parte scandire il nome di Adriano, invitavano – parole di Clerici – il di lui avversario «alla prostituzione anale»). Tanto che, su alcuni giornali inglesi, il giorno seguente vennero riportati come una truppa di beceri servitori di pizze riuniti in curva, come allo stadio. «Li ricordo anche io – dice oggi Du Pré – ma mi hanno infastidito solo all’inizio. Dopo un po’ non ci feci più caso e mi accorsi che gli anglofoni avevano preso a fare il tifo per me, quindi eravamo pari anche in quello». Panatta è ancora un po’ scocciato per la reazione snob dei londinesi: «A parte che pure questi, ovviamente, dovevano essere dipinti come camerieri, mentre erano studenti in vacanza; magari facevano un po’ di casino, d’accordo, ma non erano scorretti». Sarà, a parte qualche vaffa e un paio di fermi di polizia post partita, registrati da alcuni corrispondenti.
«Non mi sono mai sentito lo sfavorito. Avevo paura della partita, molto più che di Panatta. Ero nervoso perché non avevo mai giocato sul campo centrale di Wimbledon. Solo nel primo game, servii quattro doppi falli» Pat Du Pré
Du Pré vinse il quarto set 6-4 e Panatta era visibilmente stanco. Anche se, a suggerirgli la chiave della flessione atletica, non concorda e precisa che «al quinto set vincevo quasi sempre, alla faccia di chi dice che non ero allenato, e nel 1976 avevo vinto Roma e Parigi di fila, quando ancora erano programmati uno di seguito all’altro». Purtroppo le maledette statistiche la pensano un poco diversamente: al quinto set, Adriano vinse 15 partite e ne perse altrettante. Il 1976 non era il 1979: a 29 anni Panatta, lo si sarebbe saputo di lì a poco, si era già lasciato alle spalle i giorni più felici della carriera. E quel Du Pré che scappò subito sul 3-0 e servizio nel quinto set, per non essere più ripreso, proprio nel 1979 iniziò a collezionare successi su gente tosta; tanto che, dopo appena un mese e mezzo, avrebbe raggiunto i quarti di finale allo US Open, impresa purtroppo mai riuscita a Panatta («Quello è l’altro mio rimpianto, l’ottavo di finale nel 1978 contro Connors: ma lì fu lui a tirare un passante vincente in corsa, da lontanissimo, su un punto chiave e prese mezza riga». Jimbo vinse 7-5 al quinto). Che poi Du Pré abbia sfruttato l’effetto-sorpresa di un avversario più complicato del previsto poteva avere senso in una partita sulla breve distanza; in cinque set, è una lettura difficile da sostenere.
Il film termina con un Panatta quasi descamisado e – così appare alla stretta di mano – stravolto e madido di sudore, in opposizione al suo fiero avversario, ancora dritto sulla schiena e sprizzante energie. In emeroteca, al di là dei facili «il nostro getta al vento l’occasione della sua vita», si ritrova un capellutissimo Du Pré che si difende dall’accusa di essere un signor nessuno: non già da parte italiana, ma per mano del fuoco amico. «Il mio torneo is not a fluke», un colpo di fortuna, anche se i cronisti NBC esordirono così, con il servizio sul match: «Pat Du Pré, lo avevate mai sentito prima?» Ma si può capire: a quei tempi, gli Stati Uniti avevano in lista - tenetevi forte - sette dei primi dieci giocatori del mondo. Un monopolio, sul tennis. Cosa gliene poteva importare di quel Du Pré, che mai salì oltre la 14esima posizione e, cinque anni dopo, aveva già smesso di giocare, vinto dall’ernia del disco? Quel Roscoe Tanner che Panatta avrebbe dovuto battere per raggiungere Borg era all’apice della carriera; il suo spaventoso servizio – fatto il rapporto con gli attrezzi - era più devastante di quello di Ivanisevic. E Panatta ci aveva sempre sbattuto contro, fatte salve le sfide sull’amica terra rossa. Difatti, Tanner demolì Du Pré («Ero stanco, tutto il torneo era stato duro; la sera prima avevo cercato di cenare al ristorante con mia moglie ma la gente mi interrompeva di continuo per farmi i complimenti, non so come facesse a vivere normalmente uno come Borg»), mentre Panatta era già a casa.
A farsi raccontare l’epilogo (3-6 6-4 6-7 6-4 6-3), pare che Du Pré avesse presagito, con decenni di anticipo, il gustosissimo cameo di Adriano ne La profezia dell’armadillo, nel quale il vecchio campione se la prende con la monotonia dei giovani sparacchioni del tennis odierno, e li invita a giocare il bel tennis dei suoi tempi. A «servire uno slice e andarsi a giocare una bella volée». Ecco perché: «Sul primo match point, provai una risposta vincente di rovescio, uscì di un paio di centimetri. Mi dissi che, se ne avessi avuto un altro, avrei cercato di usare il mio colpo più sicuro, il dritto». Per procurarselo, Du Pré tirò un dritto vincente sulla parità: «Sapevo che Panatta amava servire lo slice esterno sui punti importanti da destra e scendere a rete. Allora andai in anticipo su quel servizio. Sul secondo match point, lui sbagliò la prima. Sulla seconda, riuscii ad aggirare la traiettoria e a colpire forte di dritto, lui mise la volée lunga. È stata una partita dura, entrambi abbiamo lottato. Niente di personale: spero che Adriano stia bene e si goda i ricordi di una bella carriera, pensando ai momenti belli e a quelli brutti con affetto, come faccio io. Senza rimpianti». Pof, pof.